 L’innovatore Marchionne. Nel momento in cui Federmeccanica straccia il contratto nazionale, Cisl e Uil stracciano i lavoratori, Confindustria divide il sindacato, la Fiat straccia persino le sentenze della magistratura e il governo straccia il buonsenso, l’Espresso concede la copertina a Marchionne. Lo chiama “Il sovversivo”, in pratica dice che è l’uomo del futuro. E pazienza se c’è un Paese allo sbando e il lavoro delle persone non ha più nessun lavoro. Complimenti.
L’innovatore Marchionne. Nel momento in cui Federmeccanica straccia il contratto nazionale, Cisl e Uil stracciano i lavoratori, Confindustria divide il sindacato, la Fiat straccia persino le sentenze della magistratura e il governo straccia il buonsenso, l’Espresso concede la copertina a Marchionne. Lo chiama “Il sovversivo”, in pratica dice che è l’uomo del futuro. E pazienza se c’è un Paese allo sbando e il lavoro delle persone non ha più nessun lavoro. Complimenti.
La meglio gioventù antimafia ripensa il Sud
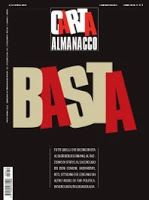 Meno male che c’è Roberto Saviano, verrebbe da dire: è solo grazie al suo lavoro che la mafia finisce in prima pagina in questo strano Paese. Peccato che c’è Roberto Saviano, verrebbe da dire: raccogliere i suoi appelli o commentarne gli scritti è infatti oggi il modo più facile e diffuso per parlare di mafia e fare antimafia, per i cittadini come per la politica, l’imprenditoria, il mondo dell’informazione. Inutile dire che la responsabilità non è di chi racconta storie che meritano di essere conosciute.
Meno male che c’è Roberto Saviano, verrebbe da dire: è solo grazie al suo lavoro che la mafia finisce in prima pagina in questo strano Paese. Peccato che c’è Roberto Saviano, verrebbe da dire: raccogliere i suoi appelli o commentarne gli scritti è infatti oggi il modo più facile e diffuso per parlare di mafia e fare antimafia, per i cittadini come per la politica, l’imprenditoria, il mondo dell’informazione. Inutile dire che la responsabilità non è di chi racconta storie che meritano di essere conosciute.
Ecco perché, per provare a ragionare di mafia e antimafia, bisogna partire dalla considerazione che non c’è consapevolezza in Italia sulle mafie e la necessità di fare dell’antimafia una pratica collettiva, generale. Oggi i clan stanno nella politica (sin dentro il parlamento, abbiamo visto) e controllano l’economia, gestiscono il traffico della droga e condizionano il mercato del lavoro, intimidiscono e uccidono, stanno nei paesi sperduti del sud e nei salotti delle grandi città del nord. Le mafie riguardano tutti, concretamente. Eppure la questione è ai margini del dibattito politico, i movimenti sociali se ne occupano occasionalmente, la gente comune la considera lontana da sé.
Non è tutto nero, naturalmente. Qualcosa si muove, di interessante, di vero. Lo dimostrano le 150mila persone che un paio di settimane fa hanno sfilato con Libera, l’associazione di don Luigi Ciotti, a Milano, la nuova capitale della ‘ndrangheta. A questo proposito, anche da qui, va rinnovato l’appello a fare del 21 marzo la giornata nazionale antimafia. Per legge. A Libera questo Paese deve molto. Innanzitutto la battaglia per la legge sui beni confiscati, la capacità di custodire il dolore dei familiari delle vittime (in 500 lavorano con Libera), la creazione di lavoro pulito sui terreni confiscati, l’internazionalizzazione dell’antimafia, la capacità di fare dell’antimafia una battaglia popolare.
E altre sono le realtà che fanno antimafia in Italia. All’Arci si deve la nascita della Carovana antimafia (un evento itinerante annuale, oggi organizzato anche con Libera e Avviso pubblico che dal 1996, raccoglie tutti gli enti locali impegnati contro le cosche). Legambiente ha invece svelato l’esistenza delle ecomafie ottenendo anche un riconoscimento legislativo, ancora parziale, per i crimini ambientali.
Straordinario è il lavoro fatto dai ragazzi di Addio pizzo: il 29 giugno del 2004 furono capaci di invadere Palermo con adesivi con la scritta “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Uno shock positivo: oggi l’associazione è un punto di riferimento concreto contro le estorsioni, promuove gli esercizi commerciali che non pagano la mazzetta ed è riuscita a determinare la nascita a Palermo della prima associazione antiracket, molti anni dopo quelle nate a Capo d’Orlando o a Cittanova che – nei primi anni 90 – sfatarono il mito dell’imbattibilità dei clan. L’antimafia sui territori è tante altre cose ancora, da indagare e raccontare. Che sia sull’onda emotiva per un fatto eclatante (le lenzuola bianche a Palermo o i giovani scesi in piazza a Locri) o frutto di percorsi più meditati. Sono nati collettivi universitari (a Firenze c’è il forum nazionale) e interessanti premi giornalistici, nascono pizzerie sociali (a San Cipriano d’Aversa) o laboratori multimediali (a Torino), web radio e riviste, aziende agricole (a Polistena o Corleone) e festival culturali, fabbriche (a Trapani) e scuole di formazione (a Milano). Centinaia di percorsi che si uniscono a quelli nati per ricordare le vittime innocenti. E’ un mondo straordinariamente vario e vitale quello dell’antimafia: energie positive e buone pratiche.
In questo contesto si inserisce l’attività dell’associazione daSud, nata cinque anni fa. Il nome esprime la provenienza delle persone che la compongono e il punto di vista attraverso il quale leggere l’Italia di oggi. Con due idee di fondo, intimamente collegate: ricostruire la memoria (condivisa dal basso e non riconciliata dall’alto) della “meglio gioventù” del Sud e ragionare attorno alla costruzione di una nuova e originale identità meridionale. Con la creatività, con la pratica politica, mettendo in rete esperienze, idee, progetti, passioni anche apparentemente lontane. Ne sono nati libri e documentari, una collana di fumetti e un archivio multimediale (Stopndrangheta.it), produzioni teatrali e campagne (e-migranti), eventi e rassegne, dossier (Arance insanguinate) e una sede romana (Spazio daSud) che valorizza le creatività meridionali e promuove i diritti sociali e civili.
Un pezzo di percorso svolto nella consapevolezza che è assolutamente necessario rimescolare i paradigmi, ripensare il modo conosciuto sinora di concepire mafia e antimafia, nord e sud, potere e critica al potere. Bisogna smettere di usare la parola (abusata) “legalità” e parlare piuttosto di “giustizia” o, come sostiene don Ciotti, “responsabilità”, uscire definitivamente dalla logica dell’emergenza per ragionare di logiche di sistema e agire con continuità, rifiutare l’idea degli eroi dell’antimafia e promuovere pratiche comuni e alla portata di tutti, rigettare il sistema della delega alle associazioni e assumere ognuno le proprie responsabilità, contrastare le amnesie di Stato e ricostruire le tessere della memoria. E ancora, lo scatto vero sarà capire che l’antimafia non è soltanto stare in un percorso “ufficiale” di antimafia. Ma contrastare i fatti di Rosarno e difendere il territorio dalle speculazioni, affermare il diritto ai servizi pubblici e denunciare i soprusi, pretendere una buona informazione e il rispetto delle regole dalla burocrazia pubblica, contrastare la precarietà sociale e rifuggire dal ricatto occupazionale. Tutto si tiene, tutto è legato da un filo che non si può spezzare. Non capirlo, significa utilizzare le categorie di chi pensa che la battaglia antimafia sia inutile, che con le cosche si deve convivere, che ci sono pezzi d’Italia da considerare persi per sempre. Significa usare gli schemi di chi ha fallito. Di fronte abbiamo scenari importanti, un’agenda stringente. L’antimafia deve guardare al Ponte sullo Stretto e all’Expo di Milano, vigilare sulle speculazioni finanziarie e rafforzare il suo ragionamento sull’uso sociale dei beni confiscati ai clan, individuare (altri) percorsi economici e contrastare la corruzione, deve saper parlare con la gente comune e deve sapersi relazionare senza subalternità con la politica imponendo le proprie priorità, creare un immaginario inedito e utilizzare linguaggi utili a farsi capire dalla gente comune e, perché no, a anche di diventare notizia. A una classe dirigente delegittimata e incapace di praticare l’antimafia (vogliamo scorrere l’elenco dei candidati e degli eletti alle regionali?), occorre rispondere con un nuovo impegno collettivo. Con la partecipazione, allargando il fronte delle alleanze e della battaglia politica. Con la rivendicazione di diritti, di un’identità. Nessuno può tirarsi fuori: la battaglia contro la mafia si vince se ciascuno fa la sua parte. Con rigore e curiosità. Senza più eroi, che poi si trasformano in alibi.
Pubblicato sull’Almanacco di Carta n.11 del 2010 “Basta” sulla nuova politica.
25 MARZO 2010
Bombe e potere
nei giorni scorsi siamo stati insieme a tanti cittadini sotto la casa del procuratore generale Salvatore Di Landro per esprimergli la nostra non rituale solidarietà. Oggi vogliamo approfittare delle pagine del Suo giornale per invitare lui e tutti i magistrati – sono molti altri, com’è noto, quelli minacciati – che lavorano nel nostro territorio ad andare avanti con la determinazione e l’impegno sin qui dimostrati.
Le intimidazioni ai magistrati, ai giornalisti, ai cittadini sono un attacco alla libertà e alla democrazia in questa città e in questo Paese. Riguardano tutti. E tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. È partendo da questa consapevolezza che bisogna avviare un ragionamento che dovrà portare – non è per nulla scontato – ad assumere la battaglia contro la ‘ndrangheta come una battaglia che sia davvero senza indulgenze, senza equivoci, senza compromessi sui principi. Andando a fondo alle questioni, ai torpori colpevoli, alle compromissioni. Partendo da due presupposti: il primo è che la ‘ndrangheta è tale per la sua capacità di stare nel Potere, il secondo è che fare davvero anti-‘ndrangheta significa banalmente occuparsi della vita delle persone, dei diritti, del proprio territorio, del proprio futuro. Tutto è legato da un filo che non si può e non si deve spezzare.
Ecco perché non possiamo non tenere presente i tempi in cui viviamo. Ecco perché occorre guardare con attenzione alla crisi di governo e, soprattutto, a quella al comune di Reggio Calabria nella quale si sta consumando uno scontro tra accuse pesanti e colpi bassi, parole irripetibili e insinuazioni violente persino nei documenti ufficiali. Nessuna parola sulla politica, nemmeno un chiarimento su qual è il vero oggetto del contendere, quali sono i poteri – da tutti evocati e da nessuno denunciati – che si agitano dentro e fuori Palazzo San Giorgio e che mettono a rischio Reggio Calabria. In questo contesto, dove si sprecano le lettere minatorie, è incomprensibile l’atteggiamento silente e confuso di un centrosinistra allo sbando.
La manifestazione.
Se guardiamo a questa situazione nel suo complesso e se – come noi pensiamo – antimafia vuol dire partecipazione, impegno, memoria, creatività allora la proposta di una grande manifestazione nazionale a Reggio Calabria non può che essere accolta con favore, nella speranza che sia l’inizio di un nuovo processo di consapevolezza dei reggini e dei calabresi e di una nuova affermazione di protagonismo del nostro territorio nei confronti del Paese. C’è un rischio però, grave. Denunciato proprio dalle pagine del Quotidiano da Angela Napoli: «Alle iniziative e all’attuazione delle stesse potrebbero partecipare e aderire persone che magari potrebbero avere delle responsabilità rispetto a tutto quello che sta accadendo a Reggio Calabria». Anche tra le persone che hanno manifestato la solidarietà a Di Landro ci sono persone e personaggi tutt’altro che al di sopra di ogni sospetto.
Ecco perché allora è giusto sottoscrivere l’appello “Quello che non ho” della Fondazione Giuseppe Di Vittorio per sostenere le richieste dei magistrati reggini al governo. Ma ecco perché occorre sciogliere dubbi e ambiguità se vogliamo ragionare di una vera manifestazione anti-‘ndrangheta. Se siamo convinti e consapevoli che la ‘ndrangheta sta nelle istituzioni, nella politica, nell’economia, se – come sostengono i magistrati – siamo di fronte a pezzi di Stato che stanno destabilizzando la nostra democrazia, dobbiamo avere la capacità di leggere le dinamiche in chiaroscuro facendoci guidare non soltanto dalle sentenze della magistratura, ma anche dal buonsenso e dal recupero di un’etica pubblica oggi più che mai indispensabile. Per questa ragione, alla politica e ai rappresentanti istituzionali, alle forze sociali e ai cittadini che vogliono scendere in piazza a manifestare contro le cosche bisogna chiedere di pronunciare parole chiare e nette sul lavoro nero e il precariato – che sono la vera grande questione calabrese – sul ricatto occupazionale e le “mediazioni” politiche per avere uno straccio di lavoro. E poi parole altrettanto chiare e nette sullo sfruttamento dei lavoratori migranti, sulle infiltrazioni negli appalti pubblici, sulle strategie (governo e regione prima di tutto) che si metteranno in atto nella gestione della sciagurata opera del ponte sullo Stretto che altro non è che un rubinetto da cui escono soldi a palate. C’è assoluto bisogno di ritrovare parole comuni, per riscrivere i contorni di una nuova e originale identità meridionale, di riappropriarsi della nostra memoria e di un racconto di noi stessi. E forse questa volta si riuscirà ad affrontare in maniera efficace una situazione che purtroppo non è nuova.
Le intimidazioni e le elezioni
Non può essere un caso che le scadenze elettorali e le crisi politiche nel nostro territorio vengano segnate sempre da bombe, minacce, lettere minatorie. Dal 2004 a oggi ci sono stati gli spari contro Saverio Zavettieri, poi le pallottole mandate ad Loiero, poi l’omicidio Fortugno, poi le finte bombe al comune di Reggio, poi – prima delle regionali – la bomba alla procura generale. L’ultimo atto riguarda Salvatore Di Landro, proprio mentre si consuma una drammatica crisi al comune e ci si prepara a fare delicatissime elezioni provinciali e comunali.
Se davvero i partiti colgono la gravità di questa fase, applichino almeno stavolta – non l’hanno mai fatto – criteri trasparenti e inequivocabili nella selezione dei candidati (abbiamo ancora davanti agli occhi lo squallido spettacolo offerto nella compilazione delle liste alle elezioni regionali e attendiamo, ora più che mai, il resoconto dei lavori della commissione parlamentare antimafia). Denuncino compromissioni e intromissioni, si facciano guardare al proprio interno. Ai cittadini spetterà di fare il resto: votino secondo coscienza. Davvero.
Ai magistrati reggini che in questi mesi hanno portato a termine importantissime inchieste chiediamo una compattezza interna oggi quanto mai necessaria e di chiarire alla città qual è la situazione, dove viviamo, dove stiamo andando, per non concedere alibi e scuse a nessuno. Reagire è urgente: bisogna mettersi in gioco «senza aspettare che il percorso di strategia della tensione che è in atto si compia. Senza aspettare – ha denunciato il procuratore di Palmi Giuseppe Creazzo, anche lui minacciato – che uno di noi venga ammazzato». Così non avremo fatto un corteo rituale.
* (Matteo Cosenza, direttore de Il Quotidiano della Calabria)
Il premio Ilaria Alpi racconta – Intervista a Danilo Chirico
Giorgio Bocca: i miei viaggi in Calabria sulle tracce di Valarioti
Di reportage al Sud Giorgio Bocca è un vero esperto. «Ne avrò fatti venti di viaggi al Sud», dice. Tutti i giornali («a parte la Gazzetta del Popolo», precisa) lo hanno «mandato giù, sin dagli anni Cinquanta: all’Europeo uno dei primi servizi era su un giovanotto che aveva rapito una ragazza per sposarla. Veniva fuori – sottolinea – questo strano mondo in cui vigevano regole di un gioco barbaro». Da allora ha sempre continuato a fare il suo lavoro di giornalista «ponendomi la stessa domanda: perché quando in Italia si fa un passo avanti, qui se ne fanno due indietro?». Non ha una risposta, neppure oggi. È sincero invece il suo “stupore” dovuto al fatto che «nel corso degli anni non c’è mai stata una vera differenza». Nessun miglioramento vero, «forse per alcune cose è sempre peggio». Un atto d’accusa pesante.
Tra le tante inchieste sul Sud, una viene spesso ricordata. Per la capacità di guardare nelle cose, perché è figlia di un viaggio lungo e pieno di storie incredibili, per l’analisi spietata e cruda dei fatti. Perché è finita in un fortunatissimo libro del 1992 “L’inferno – Profondo Sud, male oscuro”.
Scrive Bocca: «Visto dall’alto l’inferno degli italiani è bellissimo». E dice già molte cose, nel profondo. Nel capitolo dedicato alla Calabria (“Aspra Calabria”) racconta della Locride e dei sequestri di persona (e gli viene in mente il Vietnam), di Corrado Alvaro e San Luca, di medici legali e sbirri, di ‘ndranghetisti e avvocati. Racconta del suo incontro con il senatore poeta Emilio Argiroffi e delle imprese del ras della Dc di Taurianova Ciccio Mazzetta, della cosca Piromalli e del sequestro di Paul Getty jr, del giudice Cordova e dell’omicidio dell’ex presidente delle Ferrovie dello Stato Vico Ligato («era un ladro»), delle leggende e dei segni della Magna Grecia, dello storico Gaetano Cingari («era molto bravo, ricordo una sera a cena a casa sua che si vedeva il mare», dice) e di Giacomo Mancini («un politico che mi piaceva perché era un uomo coraggioso e deciso, nella politica contava», osserva). Racconta anche di Rosarno, della morte di Peppe Valarioti e della battaglia di Peppino Lavorato.
Dell’inferno del Sud, della Calabria, Bocca ascolta i suoni e respira gli odori, attraversa le viscere. E non può non chiedersi ancora oggi, a distanza di quasi vent’anni, «per quale peccato originale, per quali orgogli, per quale maledizione della storia, per quale fatalità geografica noi italiani del nord e del sud non riusciamo a fare di questo Paese un paese unito?».
Di questo siamo andati a discutere con Giorgio Bocca quando abbiamo deciso di scrivere questo libro. La sua casa di Milano sta in centro, a due passi dal Cenacolo di Leonardo. Ci riceve nel suo studio, una stanza vissuta in maniera creativa, quasi fosse quella di un adolescente. Sta dietro la sua scrivania – enorme, piena di giornali – e risponde con calma e passione alle domande. Fa spesso riferimento al passato, alla memoria, alla storia. E il fatto che siamo in una stanza che ospita in maniera ordinata per argomento migliaia e migliaia di libri – neanche fosse una biblioteca pubblica – rende tutto più credibile e avvolgente. È una leggenda del giornalismo, ma accetta di parlare e di mettersi in discussione per un piccolo libro. Si schermisce subito, non si considera la persona più adatta a parlare del Sud. Spiega: «Sono un po’ prevenuto: mio nonno era un sergente savoiardo che dava la caccia ai briganti», ride fragorosamente. «Povero diavolo – aggiunge – non capiva cosa facevano». Poi il discorso di fa subito serio. Bocca riflette ad alta voce, cerca una soluzione. Parla del Sud, ma si riferisce all’Italia di oggi. Che non gli piace, come sa bene chi legge la sua rubrica settimanale sull’Espresso. Che considera in pericolo, che quasi gli fa paura.
Si chiede spesso, ammette, «il perché nel meridione d’Italia ci sono mali così radicati», perché dalle nostre parti ci sono problemi che non si trovano in zone simili alle nostre: «non li trovi né in Grecia, né in Spagna». Analizza: «Ogni volta che uno fa un’indagine trova i colpevoli: di solito si cerca una risposta politica, si parla del capitalismo, per esempio, magari della destra. Poi però a una riflessione un po’ più profonda emerge chiaramente che la risposta è insufficiente: non si riesce mai a trovare un riparo definitivo, la vera peculiarità dei guai del meridione». La stampa non affronta i temi fino in fondo perché «è difficile e pericoloso affrontarle. I corrispondenti locali sono tutti condizionati e hanno paura che gli sparino. La letteratura s’è occupata tantissimo del Sud, la questione meridionale è stata studiata molto, ma nessuno si è occupato di capire la ragione vera» di questo arretramento. In questa indeterminatezza, Giorgio Bocca ha una certezza: «La radice è storica. Ma non riesco a capire quale è, perché ci sia questa perseveranza nel male», perché in Italia «c’è il Sud peggiore del Mediterraneo». È una domanda alla quale neppure «i meridionalisti danno una risposta».
Va a ritroso nei secoli, esclude che le colpe possano essere addebitate al periodo della Magna Grecia – «il periodo aureo», lo definisce. «Ho visitato il museo di Reggio in uno dei rari periodi in cui era aperto. Certe cose erano davvero bellissime», aggiunge – ha qualche dubbio sulla dominazione spagnola e rileva che «bisognerebbe studiare il periodo di occupazione degli arabi, che è stato importantissimo e secondo me ha avuto un effetto negativo».
Racconta di essere stato recentemente sulla costiera amalfitana e a Napoli: «L’immondizia lasciata per strada… è soltanto la camorra che vuole usare questa cosa per seppellire i rifiuti tossici o è anche la gente che se ne frega? È un mistero per me il perché questa città debba essere così autolesionista».
Giorgio Bocca ne parla, ma si capisce che in fondo non l’accetta. Merito della sua passione civile, colpa del fatto di essere stato un protagonista della Resistenza. «Tutto nasce dal fatto che avendo fatto la guerra partigiana mi ero illuso che la Resistenza e l’antifascismo fossero capaci di rigenerare l’Italia, di farla diventare un paese civile». La guerra partigiana, racconta, «è stato un periodo meraviglioso. Si aveva l’impressione che finalmente gli italiani fossero cambiati. In un periodo di grandi difficoltà – insiste – trovavi la gente che rischiava la vita per aiutarti. Arrivavi a casa dei contadini e ti ospitavano anche se c’era il cartello tedesco che li minacciava di bruciare loro la casa. La Resistenza è stata possibile – chiarisce – perché lo Stato sociale permetteva che ci fosse. Da noi le fabbriche, gli industriali, tutti collaboravano con la Resistenza. Ci davano soldi, divise, scarpe. Anche la Chiesa: i vescovi erano filofascisti, ma i parroci di campagna erano tutti partigiani». E invece oggi gli italiani «sono tornati peggio di prima. Mi sono accorto di una triste verità facendo il mio mestiere: nonostante il sacrificio di operai, sindacalisti e contadini, che sono stati molto coraggiosi, in Italia prevale sempre il peggio». E insiste: «Capisco che i giovani oggi facciano dei giornali coraggiosi o trasmissioni tv di denuncia, ma uno come me è ormai rassegnato al peggio. Forse bisogna rendersi conto che gli uomini sono fatti così, che sono brutte bestie». Tutte le volte «che lo dico me ne pento. La rassegnazione è sbagliata, mi dico che cambierà. Ma dopo cinquant’anni è sempre la stessa storia». Insiste, rincara la dose: «Non c’è niente da fare». Solo il caso, «che nella storia gioca un ruolo importantissimo, ci tirerà fuori da questa situazione. Casualmente come siamo entrati in questo vortice negativo per caso ne usciremo in qualche modo».
È lo stato d’animo di un uomo che ha combattuto per la libertà e che oggi avverte che l’Italia sta tornando indietro. Bocca non vuole sottrarsi alle analisi invocando un facile pessimismo, piuttosto partendo dal Sud e dai suoi problemi vuole parlare di come sta oggi l’Italia. Pronuncia una frase che, pur nella sua semplicità, fa male come poche: «È triste venire al sud. È costante l’umiliazione degli onesti». Un pugno nello stomaco. Parla degli intellettuali meridionale che vivono una condizione «molto difficile», ma osserva che in fondo a causa di Berlusconi «stiamo sperimentando che anche al nord viviamo tutti in una società autoritaria e arretrata». Berlusconi è riuscito a «mettere in condizioni umilianti le persone. In questo senso le differenze tra nord e sud sono diminuite. La borghesia del nord bada solo ai soldi e ai furti: la mancanza di etica è comune a tutto il Paese». Ha giudizi tranchant sulla politica: Casini? «Fa ridere, è l’erede democristiano peggiore». La Lega? «È una conferma che gli italiani sono antidemocratici e arretrati». Aggiunge lui che per primo scoprì in Italia il fenomeno di Bossi e delle camicie verdi: «È un periodo in cui il razzismo è forte. Siamo al fascismo puro. Quando ho scelto il titolo della mia rubrica sull’Espresso, l’Antitaliano – racconta – avevo capito che gli italiani avevano una voglia matta di tornare al fascismo. Purtroppo non imparano mai». Insiste, fino allo sfinimento: «La libertà l’abbiamo consegnata a Berlusconi. Anche la Resistenza, anche il Risorgimento». Si infervora: «Berlusconi è peggio del fascismo. Il fascismo è stato un movimento della piccola e media borghesia contro l’alta borghesia liberale. Mussolini era una persona intelligente. Qua siamo al qualunquismo più schifoso. C’è stata una marcia indietro». Spiega: «Penso che arriveremo presto anche allo squadrismo e alla minacce fisiche. Adesso stanno facendo campagna per abolire le voci contrarie in televisione. Un giorno o l’altro verranno a casa mia a cercare di picchiarmi. Come ha fatto il fascismo. Prendi un po’ di persone influenti e le ammazzi e cala il silenzio. Fino a qualche tempo fa – osserva Bocca come un fiume in piena – se mi avessero chiesto se era possibile il ritorno al fascismo avrei detto no. Adesso comincio ad avere paura». Ammette di aver paura anche per il suo giornale, la Repubblica: «Anche i liberali sono passati al fascismo, se De Benedetti viene messo alle corde che succede?», si domanda. Quel che è certo, secondo Bocca, è che già adesso ci sono «enormi condizionamenti della democrazia».
Un ragionamento che lo fa tornare indietro negli anni, quando «facevamo del buon giornalismo». Un atto di accusa, forse, alla politica e alla società di oggi. «Abbiamo fatto un buon giornalismo perché avevamo alle spalle il movimento operaio e i comunisti. Il Pci che è stato ad alcuni considerato, e a ragione, stalinista. Però quando arrivavo in una città, andavo alla sede del Pci e mi raccontavano cosa succedeva nell’economia. E se venivo attaccato dai fascisti, la sinistra mi difendeva. Il sindacato contadino e operaio funzionava bene ma è stato fatto fuori. Adesso c’è la sensazione di essere completamente indifeso. Quello che diceva il generale Dalla Chiesa: quando sei isolato ti possono anche far fuori. Quando hai l’opinione pubblica alla spalle ti protegge, altrimenti.. E se eliminano alcuni dirigenti della sinistra, l’unanimismo diventa un regime». Di qui la necessità di guardare indietro, di ripensare al passato: «Tutto quello che dico è memoria».
Parla anche di mafia, fuori dagli schemi: «Con il tempo mi sono fatto la convinzione che le mafie sono parte costituente della politica italiana, perché credo che ci sia la necessità che esistano. Organizzano in senso negativo questa anarchia italiana, il consenso, la voglia di anarchia, la disciplinano». Parole pesanti. E ancora: «Il mio governo è mafioso, non puoi chiedere al governo di fare una politica antimafia se è d’accordo con la mafia. Michele Greco – sottolinea – aveva una tenuta di caccia in cui andava a sparare fagiani anche il colonnello dei carabinieri. La moglie di Totò Riina ha partorito tre volte nell’ospedale di Palermo e il primario sapeva benissimo dove stava. Le mafie fanno parte costituente dello Stato italiano. Se non si capisce questo…».
Se parli con Giorgio Bocca approfitti e ti fai raccontare qualcosa della sua carriera di giornalista: «La mia carriera di giornalista? Se non c’è il caso che ti aiuta… Ero in un giornale monarchico, facevo una vita da cani e avevo un direttore di estrema destra». Poi il caso. «A dirigere l’Europeo a Milano arriva un certo Michele Serra: mi manda a chiamare e la mia vita cambia». E si ritrova a lavorare con Cederna, Fallaci, Trevisani: «Era pieno di gente in gamba». Il giornale a cui è più legato «è stato Il Giorno perché lì avevo alle spalle, un periodo molto privilegiato, l’Eni e quindi una disponibilità di soldi enorme: facevamo un giornale bellissimo, siamo stati i primi a fare i colori, le sezioni per i bambini e la moda». Poi è stato il tempo di Repubblica «che è stato un giornale con un grande direttore come Scalfari: uno che sapeva dirigere bene l’orchestra». Non è stato direttore Bocca. «No», dice. E svela un piccolo e divertente retroscena: «Un giorno durante la Resistenza comandai un’azione: dopo una lunghissima marcia per arrivare su un presidio tedesco, facemmo un’imboscata, poi tornai nella valle. Credevo che avrei avuto l’approvazione dei miei comandanti e invece la sera a cena li sentii parlare – io ero nella stanza accanto – e dicevano: quello stronzo di Bocca ha sbagliato tutto!». Ride di gusto: «Allora ho detto basta, ho capito che comandare non fa per me».
Avrebbe «voglia di fare un altro viaggio al Sud, ma alla mia età viaggiare diventa impossibile, nella vecchiaia ci sono limiti fisici con cui fare i conti». Spiega: «In quel viaggio in Calabria sull’Aspromonte ho camminato per delle ore e poi… avevo più coraggio. Quando si è giovani si crede di essere immortali. Oggi dei servizi così non sarei in grado di farli». Poi la lezione: «Il giornalismo? Guardare e raccontare. Se uno non è un cretino, la verità la vede subito. Non è difficile capire quello che succede. Si capisce benissimo dove comanda la mafia, dove i politici rubano». Di questo ci sarebbe bisogno.
(intervista realizzata nell’autunno 2009 e pubblicata su “Il caso Valarioti, giugno 2010)
